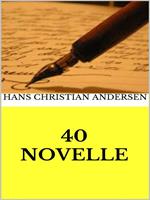Hans Christian Andersen è stato uno scrittore danese. Di umile origine (il padre faceva il ciabattino, la madre finì in un ospizio per alcolizzati), nel 1819 si stabilì a Copenaghen, dove poté studiare danza e canto e poi frequentare l’università grazie a protettori generosi, come il musicista italiano G. Siboni e specialmente J. Collin. Ma la sua restò la preparazione di un autodidatta d’ingegno, alimentata da avidissime letture; importante il precoce contatto con la narrativa di E.T.A. Hoffmann. Il suo esordio letterario ufficiale avvenne nel campo drammatico con Agnese e l’uomo del mare (1833-34), ma già nel 1829 A. aveva preso a pubblicare, sul modello di Heine, diari e taccuini di viaggio (attività ripresa anche negli anni dominati dalla produzione favolistica, per es. con Il bazar d’un poeta, 1842). Nel 1835, col romanzo L’improvvisatore, storia di una gioventù stentata come la sua, lo scrittore pervenne finalmente alla notorietà. Ma a renderlo celebre in tutto il mondo, e tradotto in più di trenta lingue, saranno le Fiabe: la prima raccolta risale al 1835-37, altre seguirono negli anni 1844-45, 1858-66 e successivi sino al 1872, per un totale di 156 fiabe. Le fiabe più antiche (Il compagno di viaggio, Il piccolo Claus e il grande Claus, I cigni selvatici) risultano derivate da motivi della tradizione popolare scandinava, ma poi A. si volse decisamente alla fiaba letteraria, utilizzando materiali disparati (Gli abiti nuovi dell’imperatore viene, per esempio, dalla Spagna). Espresse così − in una lingua svariante dai genuini modi quotidiani a raffinatezze persino leziose − ora il sopramondo della féerie (La collina degli elfi, Il folletto Serralocchi), ora l’idillio della natura (L’abete, I fiori della piccola Ida, Il rospo, L’usignolo) e addirittura certi rapporti arcani che egli sapeva cogliere tra gli oggetti più prosaici (L’ago da rammendo, Il vecchio fanale, La goccia d’acqua, Gli stracci). Parecchie fiabe tradiscono spunti autobiografici, come La sirenetta o L’intrepido soldatino di stagno o La pastorella e lo spazzacamino, che contrappongono al sogno la tenace malinconia della vita vera e alludono alle delusioni amorose dello scrittore. La matrice autentica di queste fiabe risiede tuttavia nell’ambizione di sostituire al mondo dell’esperienza una sorta di copia o d’automatico facsimile, che però non si costituisce in realtà autonoma, giacché l’autore ne mostra spietatamente il carattere labile e ambiguo: il povero soldatino mette in caricatura il tronfio orgoglio militaresco, ma anche lui non combatterà «altre» battaglie, finirà liquefatto, dissolto. Collocata in questo contesto, l’ispirazione di A. appare essenzialmente religiosa, e di una religiosità più attenta ai segnali della morte che a quelli della salvezza. Anche il lieto fine, quando c’è, rischia di suonare reversibile: la felicità del «brutto anatroccolo» trasformato in cigno serve a capire che la felicità vera era poi quell’altra, di quando guazzava nel fango, vicino alle radici del mondo.